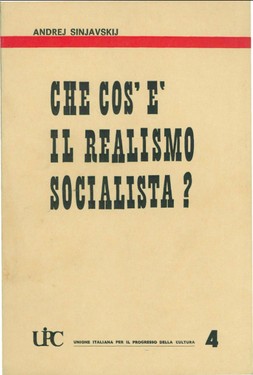Foreword

Quanto poco Andrej Donatovič Sinjavskij, autore di questo saggio sul realismo socialista, rassomigli al personaggio obliquo e proditorio configurato, nel processo a suo carico, da una Corte più incline allo scherno che alla giustizia, è dimostrato dai pochi ragguagli certi che abbiamo intorno a lui. Nato a Mosca l’8 ottobre 1925 da genitori cui il passato di rivoluzionari e combattenti della guerra civile non valse a risparmiare più tardi l’esperienza del terrore e delle carceri staliniane, Sinjavskij non fece nulla per mascherare nelle sue propensioni di critico e letterato certi interessi che lo portarono pericolosamente a indagare sull’opera di Majakovskij, della Cvetaeva, di Mandelstam, nomi sospetti al regime; a pubblicare un saggio su Picasso; a collaborare con Novyj Miir, la rivista più avanzata o liberale nel grigiore generale delle lettere sovietiche; a stringersi dal 1957 in sodalizio con Boris Pasternak: e soprattutto ad errare ed errare, sull’esempio di Tolstoj e di Gorkij, per la sconfinata Russia nel desiderio d’indagare – al di là della lakiròvka (la vernice) del socialismo e dei miserevoli paradigmi del diamàt (il materialismo dialettico) – nel mondo degli uomini. Gli fu compagna in queste scorribande, già in sé ambigue agli occhi di un potere vigilante su ogni originalità, la moglie Mascia. Ed insieme li ritroviamo il 30 maggio del 1960 nel villaggio di Peredelkino, alla periferia di Mosca, per i funerali di Pasternak, fra le migliaia di giovani che un misterioso comando nel silenzio delle autorità sull’evento, aveva convocati da ogni provincia dell’Unione: «entusiasmi da vitello» vengono consuetamente definiti simili fervori da un potere che ha paura di ciò che gli è ignoto.
A reggere la bara del poeta, cui Krusciov secondo una regola inflessibile del regime non risparmiò accuse infamanti (come non risparmiò poi la persecuzione alla fedele compagna Olga Ivinskaja e alla figlia Irina), erano Andrej Sinjavskij e Julij Daniel, I due accusati del processo di Mosca del febbraio 1966.
L’indocilità di Sinjavskij, come si vede, precedette di molto la scoperta del suo contrabbando letterario e la farsa giudiziaria guidata dal presidente dell’inappellabile Corte Suprema russa, Lev Smirnov, e spalleggiata da una disonorante «accusa sociale» affidata a due letterati di ruolo, in un’aula preclusa di fatto al pubblico. Il processo fu, in sostanza, l’epilogo premeditato di una carriera votata alla rivolta. L’imputazione per Andrej Sinjavskij (come per Daniel) è nota: avere inviato clandestinamente in Occidente opere di narrativa e di saggistica, pubblicate poi anonime o sotto lo pseudonimo di Abram Terz e giudicate – secondo l’articolo 70 del codice penale della Repubblica Federativa Russa – strumenti di agitazione e propaganda intesi «ad indebolire il potere sovietico e a diffondere basse invenzioni denigratorie dello Stato» (un codice previdente sa da che cosa conviene guardarsi). Fra gli scritti incriminati figuravano, oltre questo saggio sul realismo socialista, una raccolta di «Racconti fantastici» ed I romanzi brevi «Ljubimov» e «Si fa il processo»: presagio preciso e puntuale, quest’ultimo, dell’ineluttabile incontro dell’Autore con la polizia e la giustizia. Anche del dibattimento, svoltosi a Mosca dal 10 al 14 febbraio e concluso con la condanna dello scrittore a sette anni di campo di lavoro (cinque per Daniel), si sono avuti in Occidente abbondanti ragguagli grazie alla infedeltà di qualcuna fra il centinaio di persone reclutate dalla Corte come pubblico ed ammesse nominativamente alla cerimonia giudiziaria. E1È da notare che fra gli esclusi furono I corrispondenti di tutti I giornali non sovietici, compresi quelli delle democrazie popolari. Dalle notizie filtrate da alcune stentate ammissioni della stessa stampa sovietica si sa che il comportamento di Sinjavskij fu degnissimo. Per la prima volta nella prassi dei processi politici dell’URSS, l’imputato rifiutò di ammettere in tutto o in parte la sua colpevolezza. E concluse la sua autodifesa con l’altera rassegnazione dell’Apologia di Socrate: «Sono stato accuusato di avere scritto che ai tempi di Stalin esistevano campi di deportazione. Ma ditemi, di grazia: dove sarò condotto io stesso quando uscirò da quest’aula?».
Al XXIII Congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica (29 marzo 1966) il caso Sinjavskij era ancora troppo fresco per consentire ai custodi dell’ideologia l’oblio e il silenzio. Il compito di legittimare la sentenza fu affidato al ministro della Cultura, Ekaterina Fursteva, ed al personaggio più illustre della letteratura sovietica, il premio Nobel Michele Sciolokhov. Dalla Fursteva non poteva aspettarsi più di ciò che la sua misura poteva dare: spiegò che altro è il travaglio della ricerca creativa, altro è la calunnia deliberata contro l’ordine socialista; attribuì le domestiche irrequietezze letterarie al «diversionismo» sobillato dall’Occidente; placò l’udienza rassicurandola sulla missione dell’URSS come «faro di libertà e di cultura per tutta l’umanità» e corroborò questa tranquilla fiducia con una contabilità precisa dei libri stampati e della frequentazione dei teatri, cinematografi, sale di concerto. Che conta un Sinjavskij in un panorama tanto quieto?
Lo spiegò, dopo di lei, Michele Sciolokhov parlando come delegato dell’organizzazione di partito di Rostov sul Don. Ricorse a un vecchio proverbio russo – «Non c’è famiglia senza un mostro» – e ritrovò per lo scrittore ribelle I medesimi accenti usati nel novembre del 1956 per esortare il potere alla repressione degli intellettuali ungheresi partecipi della rivolta di Budapest: dove finisce l’ubbidienza al potere, incomincia il fascismo. Per lui Sinjavskij era soltanto un immorale e un matricida. Ma non è in questa invettiva furente che va identificata la posizione di Sciolokhov sul «caso», bensì in quello che egli aggiunse subito dopo affermando che «negli anni venti, questa gente dalla coscienza nera non sarebbe caduta sotto gli articoli ben definiti del codice penale ma sarebbe stata giudicata secondo la coscienza rivoluzionaria». Con ciò, inconsapevolmente, egli mise il dito sul punto più dolente della realtà sovietica odierna, incerta fra il garantismo costituzionale di un embrione di Stato e la violenza rivoluzionaria corrotta in prepotenza di regime. A che punti si trovi l’URSS, oggi, nella traiettoria fra la giustizia di partito e la legalità formale non può dirlo nessuno; e fino a quando la questione resterà irresoluta il socialismo russo continuerà a identificarsi con la paura: «Silenzio! Due tipi in borghese passeggiano per la città. Due in borghese. Lentamente, gravemente incedono per le vie addormentate; guardano dentro le finestre buie, I portoni, I sottopassaggi. Non c’è anima viva. Uno si chiama Vitja e l’altro Tolja. Ed io ho paura… Nessuno ha bussato; la porta si apre; l’Autore si volta e vede sulla soglia I due uomini in borghese, Modesti e pensierosi si somigliano come gemelli. Mi interrogano. Il cognome? Il nome? L’anno di nascita? È in queste occasioni che incominci a scrivere. Così venne creato questo racconto». Tale è il prologo del romanzo breve «Si fa il processo».
Alla radice della sconfinata paura sovietica c’è il dilemma intorno al quale s’arrabattano tutti I revisionismi senza osare però di formularlo nei suoi termini veri e atroci: se cioè l’assassinio, la deportazione, la Ceka nei suoi vari nomi siano ingredienti essenziali del socialismo. Se ne discute insinceramente da cinquant’anni. Dal convegno di Zimmerwald, allo scioglimento dell’Assemblea Costituente nel Palazzo di Tauride il 18 gennaio 1918, alla prima Costituzione Sovietica lo spartiacque fra i socialismi è stato l’accettazione o il rifiuto del crimine com strumento di governo. La varietà di socialismo che si chiama comunismo ha scelto per il crimine. Tutto qui; il resto sono chiacchiere.
Il realismo socialista vuol essere il metodo di una letteratura comandata, intesa a ricoprire di uno stato di consenso la sostanza oppressiva del regime. Per impedire agli uomini di guardarsi dentro o di guardare indietro, è necessario costringerli a guardare avanti, verso lo Scopo. Ma a questo punto conviene lasciare la parola a Sinjavskij e alla sua satira implacabile su uno Scopo che è stato perso di vista ed è stato rimpiazzato dal Mezzo.
Cesare Zappulli
Roma, maggio 1966
- UIPC